|
Uno
FRANCESCA E LUCIA
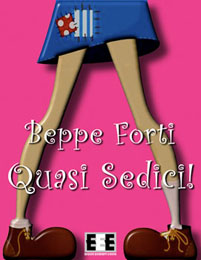 Fino a quel giorno Francesca ne aveva combinate di tutti i colori,
ma questa le mancava proprio. Prima di allora, infatti, non le era mai successo
di ritrovarsi all'una di notte in un commissariato di polizia, guardata a vista
dallo sguardo accigliato di un agente pieno di sonno. Non c'erano riviste da
sfogliare in quella spoglia sala d'aspetto e la stretta panca su cui stava
seduta non avrebbe potuto essere più scomoda. Dopo due ore d'attesa si sentì
il fondoschiena piatto come un asse da stiro, ma non appena accennò ad alzarsi
per sgranchire le gambe, il poliziotto la fulminò con lo sguardo. Fino a quel giorno Francesca ne aveva combinate di tutti i colori,
ma questa le mancava proprio. Prima di allora, infatti, non le era mai successo
di ritrovarsi all'una di notte in un commissariato di polizia, guardata a vista
dallo sguardo accigliato di un agente pieno di sonno. Non c'erano riviste da
sfogliare in quella spoglia sala d'aspetto e la stretta panca su cui stava
seduta non avrebbe potuto essere più scomoda. Dopo due ore d'attesa si sentì
il fondoschiena piatto come un asse da stiro, ma non appena accennò ad alzarsi
per sgranchire le gambe, il poliziotto la fulminò con lo sguardo.
— Seduta!
— le intimò.
— Ma
io... — provò a protestare lei massaggiandosi una natica indolenzita.
— Seduta!
— ripeté l'agente con l'aria di chi non ammette repliche.
Raramente Francesca subiva un'imposizione senza protestare. Chiunque provava a
contrapporsi a lei, madre, insegnante o amica che fosse, si trovava impelagato
in una lunga ed estenuante discussione alla quale non c'era modo di mettere fine
se non con l'imbestialirsi o con il cedere. Quella volta, però, Francesca
comprese subito che non era né il momento né il luogo per piantare una grana e
si rimise a sedere senza fiatare.
Il poliziotto di guardia aveva l'aria assente di chi sogna la fine del turno di
notte per rifugiarsi sotto le lenzuola. Un sogno talmente reale, che ogni tanto
perdeva il controllo delle palpebre e le lasciava calare sugli occhi per qualche
istante, in perfetta sincronia con il mento che gli pencolava sul petto. Il
distacco dalla realtà durava non più di due o tre secondi, poi se ne rendeva
conto, si scuoteva e si guardava attorno con aria colpevole. Gettava
furtivamente lo sguardo sulla ragazza e, vedendola ancora al suo posto, tirava
un sospiro di sollievo. Se fosse dipeso da lui, l'avrebbe sbattuta in cella di
sicurezza senza pensarci due volte, ma il commissario aveva il cuore troppo
tenero, e ora era compito del povero agente tenerla d'occhio in corridoio in
attesa che qualcuno si facesse vivo a riprendersela. A un tratto, in uno dei
suoi piccoli cedimenti al sonno, l’agente iniziò perfino a russare e
Francesca si lasciò sfuggire una piccola risata, dimenticando per qualche
istante dove si trovava e perché.
— Che
ridi a fare? — la rimproverò il poliziotto tornando improvvisamente in sé.
Il sorriso della ragazza si spense in un nanosecondo. Quell'uomo aveva ragione,
non c'era proprio niente da ridere. Una pattuglia l'aveva beccata con due amici
mentre scorrazzavano in auto a più di cento all'ora in pieno centro, e nessuno
di loro aveva la patente. Non poteva averla Francesca, poco meno che
quindicenne, ma nemmeno i due ragazzi che lei credeva più grandi e che invece
avevano appena diciassette anni, nonostante le arie da uomini fatti e vissuti
che si erano dati quando li aveva conosciuti nel cortile della scuola qualche
giorno prima.
Il titolare dello studio di architetti in cui lavorava mamma Lucia aveva il
pallino di discutere di importanti questioni di lavoro attorno al tavolo di un
noto ristorante e capitava spesso che la donna uscisse di sera lasciando da sola
Francesca. La ragazza ne approfittava alla grande e, appena la madre se ne
andava, sgusciava fuori di nascosto anche se era buio pesto. Finora era sempre
riuscita a rientrare prima di lei, infilandosi sotto le coperte e fingendo di
dormire come un angioletto innocente, ma quella sera le era andata male.
La pattuglia aveva inseguito i tre ragazzi per le strade di mezza città come
fossero pericolosi delinquenti e quando, finalmente, li aveva costretti ad
accostare, si era verificato un fulmineo e confuso movimento all'interno della
macchina che uno dei due maschi aveva sottratto di nascosto al padre. I
poliziotti si erano avvicinati cautamente con le armi in pugno, ma avevano
trovato vuoto sia il posto di guida, sia quello accanto, mentre i tre amici,
pigiati sui sedili posteriori, li sbirciavano con l'aria più innocente del
mondo.
Gli agenti non avevano gradito lo scherzo. Francesca era stata fermata assieme
ai compagni, caricata sulla volante della polizia, portata in commissariato,
trattata come una criminale e perquisita da una poliziotta perfino dentro le
mutande per controllare che non nascondesse della droga. Che vergogna!
Mezzanotte era ormai passata e della madre di Francesca non si vedeva nemmeno
l'ombra. Il suo capo pretendeva che durante le cene di lavoro i collaboratori
spegnessero i cellulari e Lucia si dimenticava sistematicamente di riaccenderlo,
così l'agente di guardia aveva dovuto accontentarsi di lasciarle un messaggio
sulla segreteria telefonica di casa.
I due amici se n'erano già andati da un pezzo, presi in consegna dai rispettivi
genitori. Uscendo dal commissariato scuri in volto, i loro familiari avevano
gettato uno sguardo truce su Francesca, attribuendole la colpa di tutto, come se
una ragazzina di neanche quindici anni fosse davvero in grado di traviare due
ragazzi di quasi diciotto.
— Cosa
ci si può aspettare da una come lei che porta il cognome di sua madre?
No, in realtà non l'avevano detto, ma Francesca era sicura che l'avessero
pensato. Così sicura che lei stessa, a volte, tentava di giustificare la
propria irrequietezza agli occhi di mamma Lucia attribuendone la causa
all'assenza di un padre. Era sicura, infatti, che una figura paterna sarebbe
riuscita a contenere la sua esuberanza di adolescente inquieta. Era solo un
alibi, lo sapeva benissimo, ma come argomento da opporre a Lucia non faceva una
grinza e lo tirava fuori a ogni litigio.
Per quanto riguardava la presenza materna, invece... beh, si poteva definire
madre quella casinista che si ritrovava per casa? Francesca se lo chiedeva
spesso. Più che una madre, infatti, la sua sembrava una sorella maggiore
rompiscatole che cercava disperatamente di imporle regole che lei stessa non
riusciva mai a rispettare. Lucia era sempre di corsa e si fermava solo per
rimproverare la figlia per quel che faceva e non faceva. Con la presenza di un
uomo in famiglia le cose sarebbero andate diversamente, Francesca ne era sicura
e fantasticava attorno a quadretti familiari molto simili a quelli che vedeva
negli spot pubblicitari, con padre, madre e figli sempre felici e contenti di
fare colazione con una famosa marca di biscotti, o pranzare in perfetta armonia
con un certo dado da brodo.
La minestrina fatta con il dado era la base dell'alimentazione di casa Martini.
Lucia lo metteva dappertutto risparmiando, forse, solo il caffè-latte e il tè,
nella vana speranza che la sua insipida cucina si arricchisse di un po' di
sapore. La donna era sicuramente brava come architetto, ma come casalinga e
cuoca era una vera catastrofe. Per fortuna un paio di volte alla settimana
andavano a pranzo o a cena dalla nonna e ogni tanto Maria Dolores, la colf
colombiana, si impietosiva e si metteva ai fornelli preparando qualche gustoso
piatto sudamericano. A prestare fede alla pubblicità, con tutto quel consumo di
dadi, tra lei e sua madre avrebbe dovuto regnare un'armonia e una concordia
invidiabili. Tuttavia l'unica cosa in cui sembravano andare d'accordo era nel
finire ogni volta a litigare su tutto e per tutto.
Francesca aveva smesso da un pezzo di giocare con le bambole, ma alla bimba
calma e riflessiva, un po' ingenua e pacioccona che era stata, si era sostituita
in breve tempo una creatura inquieta e con una gran voglia di crescere. Come un
serpente durante la muta, la ragazza tentava in tutti i modi di scrollarsi di
dosso ogni traccia dell'infanzia, ma era costretta a un'interminabile e
quotidiana polemica con la madre che si ostinava a vedere in lei sempre la
stessa graziosa bambolina che era stata da piccola. Eppure Francesca, ormai, era
alta come sua madre tanto che, pur essendo più esile, avrebbe potuto usarne il
guardaroba, anche se difficilmente si sarebbe messa addosso quei tailleur sobri
ed eleganti da professionista in carriera. Non avrebbe mai rinunciato, infatti,
alle mini e ai jeans a vita bassa che portava abitualmente, nonostante gli
inefficaci rimbrotti materni.
Madre e figlia apparivano per il resto quasi come due gocce d'acqua: stesso
ovale delicato del viso, stessa carnagione pallida, stessi tratti regolari,
stessi grandi occhi castano chiari e stessi capelli, castani come gli occhi, con
in più un'impercettibile sfumatura di rosso che Lucia amava accentuare con
civetteria grazie ai sapienti ritocchi del parrucchiere di fiducia. Un miope
avrebbe potuto scambiarle per due gemelle, ma mettendosi gli occhiali si sarebbe
accorto di qualche lieve differenza negli zigomi, nel mento, nelle sopracciglia
e nelle piccole ma inesorabili rughe d'espressione di Lucia, regalo non molto
gradito degli anni.
La somiglianza tra madre e figlia non si limitava all'aspetto fisico. Crescendo,
infatti, Francesca aveva rivelato un carattere molto simile a quello di Lucia,
caparbio, spigoloso e poco incline al compromesso. La somiglianza era
letteralmente esplosa all'inizio dell'adolescenza e Lucia si rammaricava di non
riuscire più a riconoscere nella figlia la piccola e adorabile Paciocchi,
nomignolo che le aveva dato quand'era ancora poco più che poppante e sembrava
pacifica, serena e tonda come una pallina. Adesso che era cresciuta, Francesca
appariva a volte alla madre come un'intrusa odiosa e intrattabile che girava
ciondolando svogliatamente per casa, studiava poco e male, aveva un pessimo
rapporto con il mondo degli adulti e possedeva una straordinaria predisposizione
per mettersi nei guai.
(...)
Torna
a Narrativa per Ragazzi
|

